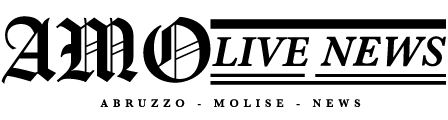Non ricordo di essere mai stata ad Alfedena, credo però di esserci passata per andare al lago di Villetta Barrea. L’attraversamento era d’obbligo, da Isernia, risalendo il passo del Macerone, ai tempi croce e delizia dei ciclisti impegnati nelle tappe del giro d’Italia, percorso tra i più ripidi dell’itinerario, ma molto bello. Qualche sera fa, un amico al quale confidavo il mio rincrescimento rispetto a tanti luoghi sconosciuti e mai visitati del nostro territorio, mi disse: “ Per andare a Villetta Barrea, negli anni in cui sei andata tu, devi esserci passata necessariamente ad Alfedena, essendo il paese nella direttrice ”.
Da quel momento qualcosa mi è tornata in mente di quella meravigliosa giornata in quei posti incantevoli di cui conservo, gelosa, le belle foto di tutti noi e dei nostri bimbi, in quel lembo di paradiso in terra, 914 m. di altezza, sulle rive del Rio Torto, ai piedi dei massicci della Meta e del Monte Greco nel vastissimo territorio del Parco Nazionale.
Su Alfedena, ovviamente ho chiesto notizie, ho letto, mi sono informata perché attratta da un percorso linguistico letterario di matrice popolare, tracciato dal grande pensatore, scrittore, saggista, regista, che è stato Pier Paolo Pasolini. “ Questo libro- si legge nella prima edizione del Canzoniere Italiano, pubblicato da Guanda nel 1954, l’ha scritto il Popolo italiano”.
In realtà è così. Il Canzoniere non è un libro ma un monumento come pochi, anzi unico, dove il racconto si snoda sul filo della fantasia delle genti che hanno ritmato il tempo e il ciclo della vita attraverso i loro canti. E “ il Canto è un bisogno del popolo – scriveva il poeta siciliano Ignazio Buttitta– non è un sollazzo”. Mi vengono in mente, a tal proposito, i canti ritmati delle clapas e l’intermezzo delle donne intente a pestare il grano, i canti delle risaie del Trigno, dei mietitori di spighe a Tavenna tanto per citarne alcuni. Che dire dei canti religiosi? Non quelli dell’ufficio, ma quelli delle feste, delle sagre e delle ricorrenze come i Fuochi di Sant’Antonio il 17 gennaio e la seconda domenica di luglio con la Festa di Santa Maria Salomè e San Pietro, patrono di “Alfedea “ come scriveva Tito Livio.
“O cara matra , i’ me n’aggia da ire / a Gerusaleme pè la pasqua fare/ si ‘sto viage me potrà sortire, / dammi la binnizione mi ni voglio annare” “ Fije, te benediche li trantatrè anne,/ Li nove mese t’ho purtate ‘riventre: te benedche e ‘latte che t’ho date: vattene, fije mie, vattene ‘npace”.
O cara madre, cantavano le donne di Alfedena nel periodo pasquale, legando alla metafora del viaggio, la via crucis di Gesù che lo porterà sul Monte Calvario, un viaggio che non può intraprendere senza il consenso e la benedizione di sua madre. Maria, madre e a sua volta figlia tanto desiderata …
Ecche, Sant’anne a ‘n’urtecelle steve / Piebe de doglie e de malanconìe. / se volta al ciel e ce vidde n’aucelle/ Che sopr’a r’arbre ce ficea ru nide. / se volta e dice : AH Segnore Segnore/ So aucelli, e pure fanne famiglie : / e i che so’ donna non la pozzo fare?/ Carò l’angel da ru ciele e dicette: “ Zitte Sant’Anne, ne nte dubetare : / Tu farraji ‘na fijola tanre care/ reggina der ru ciele s’ha da chiamare,/ e po’ farrà ‘nu Fije tante belle, / Patrone de rru ciele e de la terre”. ( Alfedena Barrea , Pier Paolo Pasolini. Canzoniere italiano, prima edizione, Guanda 1954).
Ecco Sant’Anna che intenta ai lavori dell’orto, ascolta piena di dolori e di malinconia il canto degli uccelli intenti a costruire il loro nido. “ oh Signore, se anche gli uccelli possono creare una loro famiglia, perché non posso farlo anch’io?”. Avrai una figlia che sarà la regina del Cielo, le predice l’angelo del Signore, nella narrazione in una di quelle varianti dialettali dal substrato italico , su cui si è sviluppato il dire delle popolazioni nel passaggio dalle parlate romanze alle lingue volgari generate dal latino ,confluite nel folclore, definito come la “ preistoria contemporanea”.
Ad “ Aufidena” la storia e la protostoria, non sono solo nella parlata ma nelle testimonianze archeologiche di un passato remotissimo quando nel territorio splendevano la civiltà e la cultura pre romana.
Fondata dai Sanniti, il paese sorge in un’area che ospitava una vasta necropoli di epoca protostorica, portata alla luce a partire nel 1882, simile per molti aspetti agli altri due siti di Barrea e Opi; similitudini che hanno condotto gli storici a parlare di una “vera e propria facies culturale dell’Alto Sangro”.
La Torre Ottagonale, che nel Medioevo fungeva da avvistamento, è ciò che rimane del Castello Medievale, nel centro storico, accessibile da una scalinata rimessa a nuovo e da cui si dipartono tracce delle mura antiche. La parte più suggestiva del paese è la natura . La vista è attratta dal bacino della montagna Spaccata e dalle alte cime del massiccio della Meta. Montagne e pietre che hanno reso importanti i selciatori e gli scalpellini famosi per aver lavorato i blocchi di selce e posato i sanpietrini nelle strade e nelle piazze di Roma, tra queste, piazza San Pietro.
Ad Alfedena, i giorni precedenti la Pasqua l’attenzione si sposta alla preparazione di piatti e dolci tipici della tradizione: la pupa per le femminucce o “ru cavagliucc” per i maschietti. “ Si salutava la primavera e la rinascita ma era anche un auspicio. Venivano anche preparate per le cerimonie del fidanzamento ufficiale. Le pupe impreziosite con un uovo sodo posato sul ventre e intrecciato , venivano poi donate alle giovani spose o fidanzate auspicando fertilità.
Ma la regina dei pranzi di festa è lei la zuppa, la famosa zuppa dei conviti nuziali. Zuppe e spose.
Richiamano le antiche tradizioni degli abitanti della montagna, anche in diverse latitudini. Se è vero che ognuno e ogni cosa ha qualcosa di sé da qualche parte del mondo, la zuppa di Alfedena ha qualcosa di sé tra i monti del Ponto, in Anatolia. “ Ezo Celin Corbasi “ è la zuppa della sposa .Deriva dal nome di una donna Ezo Celin, prigioniera e vittima di uno scambio di spose. Vissuta a Gaziantep, meta di carovane, e via della seta, occupata a suo tempo dai Romani, tra lingue greche e turche, è ricordata per le sue zuppe con le quali, come da tradizione, vengono ancora oggi nutrite le spose alla vigilia del loro matrimonio. Tra gli ingredienti principali, i prodotti di quelle terre: grano spezzato ( bulgur), lenticchie rosse, riso, cipolle, menta, limoni, spezie e sale.
Anche nei paesi abruzzesi e molisani, quando i conviti di matrimonio si facevano nelle abitazioni, la famiglia della sposa affidava alle cuoche che custodivano molto gelosamente la ricetta della zuppa, l’incarico di non lesinare gli aromi. Pane tagliato molto sottile, abbrustolito e passato nel vino bianco aromatizzato con cedro, cannella e cinque varietà di liquori, con mandorle e cioccolato fondente. Come in Turchia, dove il piatto tradizionale della zuppa della sposa dai sapori speziati, emblema dei valori della tradizione, è diventato un di attualità, le pietanze antiche, onorano le tavole nei giorni più importanti dell’anno e non solo. E una zuppa della sposa a pasqua ad Alfedena, è un rinnovo di tradizioni, di gusto, di fantasia, di festa e di grande convivialità.
ZUPPA DELLA SPOSA (secondo la tradizione di Alfedena)
La ricetta che qui si riporta, è stata cortesemente fornita dalla signora Vincenza Quaranta di Alfedena
L’usanza voleva che il giorno dopo le nozze, la mamma della sposa donasse una gallina alla madre dello sposo per preparare la pietanza, che si doveva consumare insieme ai commensali di entrambe le famiglie.
Ingredienti
Gallina anziana – Indivia riccia (lessata e tagliata fine) – 1 pomodoro pelato – sedano (tagliato a pezzetti) – polpettine con carne macinata di vitello – scamorza appassita (tagliata a cubetti) – Pane raffermo tagliato a quadrettini (fritto in olio di semi appena dorato) – uovo sodo a pezzettini (facoltativo).
Polpettine
macinare la carne di vitello (più volte), amalgamare con uovo, mollica di pane raffermo e sbriciolata, aggiustare di sale e preparare piccole sfere di carne che andranno leggermente soffritte nell’olio di semi (giusto per far amalgamare gli ingredienti).
Preparazione
Preparare il brodo riempiendo una pentola con acqua e sistemarvi la gallina. Appena la prima bollitura, eliminare la schiuma che si forma in superficie e aggiungere il pomodoro, la cipolla, una costa di sedano e la carota; aggiustare con il sale e lasciare bollire almeno due ore.
In un’altra pentola mettere l’indivia tagliata a pezzettini, le polpettine ed il sedano e aggiungere il brodo rigorosamente filtrato (deve risultare limpido e di colore biondo) . Far bollire a fuoco lento per altre 3 ore fino attenere un gusto ricco e saporito.
Impiattare
Prelevare un mestolo e mezzo dalla pentola con l’accortezza di prendere la verdura, aggiungere il pane fritto, la scamorza e l’uovo sodo (facoltativo.)
Fernanda Pugliese