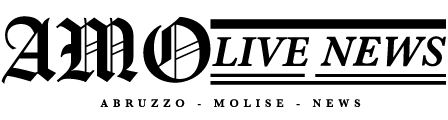Lo scorso anno furono sei i paesi legati alle tradizioni del fuoco che sfilarono ad Agnone per la prima Festa dei “Fuochi Rituali”. Il prossimo 2 dicembre ne saranno 15, numero questo destinato ad aumentare nelle prossime edizioni.
Lo scorso anno furono sei i paesi legati alle tradizioni del fuoco che sfilarono ad Agnone per la prima Festa dei “Fuochi Rituali”. Il prossimo 2 dicembre ne saranno 15, numero questo destinato ad aumentare nelle prossime edizioni.
Obiettivo degli organizzatori, infatti, è stato quello di ricercare ulteriori costumi e usanze popolari accomunate dallo stesso tema: il fuoco. Un lavoro certosino che ha permesso ai promotori dell’iniziativa di estendere l’invito al vicino Abruzzo, alla Puglia e alla Toscana.
“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di organizzare il primo appuntamento italiano incentrato sulle tradizioni e sui riti del fuoco” ha dichiarato il Sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ha aggiunto: “Già l’anno scorso avevamo promesso di allargare i confini e stiamo riuscendo nell’intento. Sapere che Agnone ospiterà rituali molisani, abruzzesi, pugliesi e toscani è un grande risultato che va nella stessa direzione della candidatura a capitale della cultura: rendere il nostro borgo un esempio di fusione e di collaborazione tra realtà vicine e distanti”.
Ma vediamo nel dettaglio, grazie allo storico Domenico Meo, i paesi partecipanti con le loro tradizioni legate al fuoco.
- Ndocce di Belmonte (Molise)
Le ndocce sono costruite con le canne e qualche rametto di ginestra alla punta, sono alte circa 3 metri, hanno forma conica e spessore variabile. Le torce, tutte singole, ardono vicino le masserie delle borgate e solo qualcuna viene fatta bruciare, la sera della vigilia di Natale, davanti il sagrato della chiesa del Santissimo Salvatore.
- Ndocce di Civitanova del Sannio (Molise)
Con il fuoco benedetto al mattino, calate le prime ombre della sera, gli ndocciatori accendono le torce: tronchi di faggio di due metri e mezzo spaccati per un terzo ad un’estremità. Disposti su due file ordinate e al suono della zampogna proseguono fino al falò sfavillante che arde “Fuori la porta”.
- Farchie di Fara Filiorum Petri (Abruzzo)
Con un rito antico che si ripete ogni anno il 16 gennaio, vigilia della festa, il paese rinnova la sua devozione al Patrono S. Antonio Abate. Lo ringrazia per il miracoloso intervento che scongiurò il saccheggio da parte dell’esercito napoleonico nel 1799 accendendo davanti alla sua chiesa grandi torce di canne chiamate Farchie, trasportate fin lì da ogni contrada, solo quella di Fara centro è recata a spalla. L’anima, il nucleo centrale, viene ricoperta con fasci di canne saldamente tenute insieme dai legami di salice sapientemente annodati, fino a raggiungere le dimensioni di 80 cm di base per 8 metri di altezza. Nel primo pomeriggio del 16 gennaio le Farchie, addobbate con bandierine e l’immagine del Santo, giungono sul piazzale dove verranno innalzate e bruciate.
- Le Laure di San Giorgio di Mirabello Sannitico (Molise)
Il rito del fuoco chiamato le laure si tiene a Mirabello Sannitico (CB) il 16 e il 22 aprile in occasione delle festività dedicate al Santo Patrono San Giorgio (23 aprile). Vengono bruciate semplici fascine di ramoscelli e i resti più piccoli delle potature della vigna e degli alberi da frutta. Le campagne, il borgo antico e la collina di San Giorgio si “infuocano” a partire dalle 20.30 e “bruciano” fino a tarda serata. La leggenda locale vuole che nel Medioevo, il paese fu oggetto di incursione da parte di soldati barbari, venendosi a trovare in una situazione di estrema difficoltà. La popolazione mirabellese rivolse quindi le sue preghiere al Santo Patrono Giorgio che aiutò il popolo a respingere il nemico, trasformando i tanti ramoscelli delle potature in valorosi soldati.
Farchie di Montefalcone nel Sannio (Molise)
Le farchie, affastellate con lunghe listelle e tronchetti, ordinate in una sorta di processione al suono e al canto “sul fieno e sulla paglia”, attraversano il paese per giungere vicino la chiesa di San Silvestro; qui poste su particolari treppiedi ardono rivolte al cielo in attesa di Gesù che nasce. 
- Faglia di Oratino (Molise)
È un’enorme torcia di canne dell’altezza di 13 metri per il diametro di uno che, sormontata dal “capofaglia”, il 24 dicembre a sera verso le 19,00, viene portata a spalla da 40 uomini dalla periferia del paese alla chiesa Madre dell’Assunta dove si procede alla suggestiva elevazione e rituale accensione.
- Ndoccia di Pietrabbondante (Molise)
Falò di ginestre sapientemente legate e preparate con cura, poste davanti le case e accese ai rintocchi dell’Ave Maria. La vigilia di Natale tutta la famiglia si riunisce intorno al fuoco che illumina a giorno i monti dell’Antico Sannio garantendo prosperità e salute.
- Torciata di San Giuseppe e il bruciamento dell’invernacciu di Pitigliano (Gr-Toscana)
La Torciata di San Giuseppe di Pitigliano (GR) ha origini ancestrali ed è legata ai riti propiziatori equinoziali dell’arrivo della Primavera. La sera di San Giuseppe, verso le 21.00, la processione dei Torciatori, giovani incappucciati con rustici sai e con pesanti fasci di canne infuocate sulle spalle, iniziano a salire gioiosamente dalla Cava del Gradone e, una volta raggiunta piazza della Repubblica, si dispongono intorno all’Invernacciu, un “totem” vegetale intessuto di canne che impersona l’inverno. I vigorosi giovani, al ripetuto grido “Evviva San Giuseppe”, creano un cerchio magico e, quasi ad eliminare simbolicamente l’inverno, lo incendiano con le fiamme del fuoco “nuovo”.
- Farchia di Roccavivara (Molise)
A Roccavivara la “Farchia” viene realizzata e accesa sia vigilia di Natale che il 17 gennaio festa di Sant’Antonio Abate. La costruzione avviene posizionando nella parte esterna e in maniera circolare pali di quercia tenuti insieme da cerchi di ferro, mentre all’interno si pongono legna spaccata e fascine per favorirne la combustione. La “Farchia” è di circa un metro di diametro per minimo tre di altezza.
- Farchie di Salcito (Molise)
Le farchie sono veri e propri fasci di canne, di altezza variabile, infarciti di ginestra e legati tra loro. La vigilia di Natale, una volta accese, ragazzi e giovani danno inizio ad un giro itinerante di questua tra le case. I compaesani, gradendo l’omaggio, offrono in cambio regalie in denaro e cibarie.
- Fracchie del Venerdì Santo di San Marco in Lamis (FG-Puglia)
Le Fracchie sono enormi coni di legna bruciati la sera del Venerdì Santo a San Marco in Lamis (FG). Secondo la tradizione servono per illuminare il cammino della Madonna Addolorata alla ricerca del Figlio nei sepolcri. L’uso delle fiaccole è attestato già nel 1490 e fino alla metà degli anni ’20 le fracchie erano piccole e portate a spalla da una sola persona. Nel 1925 si ha la prima fracchia su ruote grazie alla nobildonna Michelina Gravina. Dal 1955 la processione dal giovedì viene spostata al venerdì Santo. Dagli anni ’60-70 le fracchie cominciano ad assumere dimensioni sempre più grandi. Nel corteo processionale sfilano prima le fracchie piccole, poi la statua della Madonna Addolorata, il clero e i fedeli e infine le fracchie più grandi. Grida e fiamme creano un’atmosfera da inferno dantesco. Le ruote stridono, la fracchia “sputa fuoco e la brace ardente sfavilla. La fracchia ha forma conica è costruita con cerchi di ferro esterni e adagiata su un carretto con ruote di ferro; reca un tronco per l’ossatura e nella parte interna è infarcita di quintali di legna di quercia o di castagno, una serie di accessori utili per il trasporto completano l’artistica costruzione”.
- Fiaccole Abbadia San Salvatore (Siena)
Quella delle Fiaccole di Abbadia San Salvatore (SI) è un’antichissima tradizione che si rinnova ogni 24 dicembre. Tipiche cataste di legna a forma piramidale alte fino a sette metri le “fiaccole” vengono costruite in ogni angolo del borgo medioevale amiatino e con il loro fuoco illuminano la notte di Natale. Una preparazione che impegna i “fiaccolai” per mesi e che coinvolge l’intera comunità badenga, sposando simbolici significati pagani e religiosi.
Sono “figli del fuoco” infatti gli abitanti dell’Amiata, montagna di origine vulcanica che nelle sue viscere nascondeva la lava incandescente. Una montagna amata e sentita come madre, come presenza sacra, che i badenghi celebrano attraverso le loro Fiaccole.
- Ndocce di Bagnoli del Trigno (Molise)
Le ndòcce della vigilia di Natale sono di scena a Bagnoli del Trigno. Qui il rituale è a carattere familiare e, mentre un tempo le torce (fisse) ardevano pressoché davanti ad ogni casa, al presente sono conservate solo da poche famiglie. Le ndòcce, vale a dire torcioni di fascine, ginestre o canne secche la cui base di appoggio è un treppiedi di legno o di ferro, si accendono all’imbrunire, dopo il rintocco dei sacri bronzi della chiesa di Santa Maria Assunta, mentre un grande falò brucia in piazza Umberto I.
Nonostante l’incessante spopolamento, la sera del 24 le ndòcce ardono ancora nelle borgate Colardoni, Coste di Sopra, Macchia la Cerva, Santo Ianni e nelle case sparse della campagna. La ndòccia di Bagnoli, serbando un’antica usanza, viene spenta simbolicamente con il vino nuovo spillato dalla botte. Il gesto racchiude buoni propositi per i raccolti e per tutta la comunità. 
- Ntosse di Santo Stefano di Sante Marie (Santo Stefanoè una frazione di circa 250 abitanti di Sante Marie (AQ-Abruzzo)). A spiegare questa tradizione è Isabella Tomei:
“A Santo Stefano, frazione del Comune di Sante Marie, la vigilia di Natale è caratterizzata da tradizioni che intrecciano religione e vita di comunità. Si tratta di ritualità molto sentite da tutti i paesani e da coloro che tornano da fuori per parteciparvi.
Tutto incomincia il pomeriggio quando dopo la partecipazione alla Santa Messa, verso le 18 circa, tutti i paesani si radunano nella piazza da dove, guardando la montagna di Monte Faito, si può intravedere la cosiddetta “capanna”, chiamata così perché dal basso somiglia alla cappa di un camino. Si tratta di una catasta di fascine che viene bruciata formando un grande falò, il tutto accompagnato da fuochi pirotecnici che possono essere visti da molti comuni della Marsica.
Mentre il fuoco si spegne la popolazione rimane attenta a guardare la direzione del fumo, in quanto la tradizione vuole che se esso volge a levante, cioè verso le vigne, ci sarà molta uva, se invece va a ponente, quindi verso i castagneti, ci saranno tante castagne; mentre se piega a sud verso i campi ci saranno molti cereali e se va a nord, verso la montagna, significa che ci sarà scarsità in generale.
Dopo i vari pronostici sull’agricoltura per l’anno venturo, gli abitanti si recano nelle case per il tradizionale cenone, con astinenza dai grassi, composto principalmente da verdure come la pastinaca (carota di natale bianca), la rapa rossa e i” frittelli” di cavolfiore.
Verso le 23,30 il paese è di nuovo in fermento per la tradizionale processione delle “Ntosse”, una specie di scopa preparata con lunghi rami di quercia spaccata sulla punta, a cui vengono incastonate delle stecche o fasci di ginestre secche. Le ntosse sono portate in giro dai giovani lungo le vie del paese, in modo da  illuminare le strade fino ad arrivare in piazza, per poi gettarle in un grande fuoco comune. A seguire c’è la tradizionale celebrazione della messa di mezzanotte.
illuminare le strade fino ad arrivare in piazza, per poi gettarle in un grande fuoco comune. A seguire c’è la tradizionale celebrazione della messa di mezzanotte.
Quando ancora non esisteva l’energia elettrica, questa antica tradizione permetteva a tutti di poter andare alla messa di mezzanotte grazie all’illuminazione delle fiaccole.
Questa tradizione è stata tramandata sino ad oggi, regala una magia particolare alla Vigilia di Natale”.
Infine la Ndocciata di Agnone.
Sulla sfilata dei torcioni ardenti agnonesi, considerato il più antico rito del fuoco d’Europa, si è detto davvero tutto. Dalle cinque contrade che sfilano, alle centinaia di portatori (tutti uomini) indossanti la cappa ovvero l’antico mantello in lana dei pastori: dalle torce singole ai ventagli fino a 22 lumi che alla fine ardono tutte insieme nel Falò della Fratellanza. Corteo anticipato dai figuranti dell’antica Civiltà Contadina che portano con loro animali, manufatti artigianali, messi, dolciumi tradizionali del Natale. Un’onda di fuoco che emoziona e da cui nasce proprio la Festa dei Fuochi Rituali.