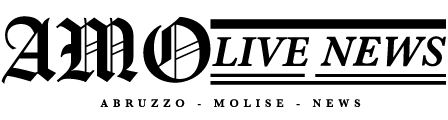Il 29 luglio prossimo a partire dalle ore 18,00, Guglionesi si interrogherà sull’insostenibilità della moda e dell’inquinamento da essa derivato. Cambiare si può rendendo sostenibile la sua filiera. Dal Molise, un forte segnale di partecipazione al cambiamento anche in virtù delle nuove proposte messe in campo da piccoli e grandi artigiani e industriali.
L’industria tessile è responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas serra: consuma più energia del trasporto aereo e di quello marittimo messi insieme. Nell’ambiente marino globale, l’8% delle microplastiche accumulate nei fondali oceanici, proviene dal lavaggio dei tessuti sintetici (poliestere, acrilico) come documenta l’Agenzia Europea dell’Ambiente. Ma a inquinare non è soltanto il processo di produzione e lavaggio degli abiti: dobbiamo, infatti, considerare il disastroso impatto della sovrapproduzione.
Ogni anno nella U.E. vengono buttati via circa 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, pari a circa 11,3 Kg a persona. E’ come se ogni secondo, l’equivalente di un camion carico di vestiti venisse bruciato o seppellito in discarica. Di questa sovrapproduzione, solo l’1%, in ambito mondiale, viene riciclato per produrne dei nuovi.
IL 26 gennaio 2023 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “ReSet the trend – make fast fashion out of fashion” volta a sensibilizzare i cittadini europei sui danni ambientali e sociali prodotti dal “Fast Fashion” (la cosiddetta “moda veloce”) che costituisce un modello produttivo fondato sulla continua e rapida produzione di altissimi volumi di abbigliamento di “bassa qualità”, venduti a “prezzi bassi”.
Un modello, questo, che:
a) produce una enorme quantità di materiale (di breve “vita”) che finisce, per l’85% dei casi, in discarica;
b) alimenta (oggettivamente), in ragione dei suoi prezzi bassi, la ricerca del “minor costo del lavoro” che, spesso viene realizzato attraverso condizioni di lavoro non sempre rispettose della dignità umana (è ancora vivo il ricordo delle 1134 vittime del crollo del Rana Plaza – Bangladesh).
Nel marzo 2022 la Commissione Europea ha adottato una strategia per il sistema moda che punta, entro il 2030, su produzioni tessili – moda: durevoli, riciclabili, privi di sostanze pericolose e rispettose dei diritti sociali e ambientali.
Dal “fast fashion” allo “slow fashion”: da una moda che si consuma rapidamente ad una moda fatta per durare a lungo e incentrata sulla sostenibilità ambientale e sociale; capace di rispondere, attraverso la tracciabilità del ciclo di lavorazione (passaporto digitale dei prodotti), alla crescente domanda dei consumatori sul “chi” e sul “come” vengono realizzati i “capi”.
Consumatori che, come evidenzia lo studio Acenture Strategy, si aspetta, per l’83%, risposte su “chi” e su “come” vengono realizzati i “capi” e, per il 73%, chiede alle aziende posizioni chiare su questioni sociali, culturali e ambientali. Il 24 aprile del 2013 a Savar, nei pressi di Dacca (Bangladesh), 1134 operai del tessile abbigliamento perirono nel crollo di un edificio commerciale.
In quell’edificio fatiscente di otto piani, operavano aziende che confezionavano “capi” di abbigliamento ed i lavoratori erano costretti a lavorare in un luogo insicuro incapace di reggere il peso delle vibrazioni dei macchinari pesanti. Sotto le macerie del crollo vennero trovate le etichette di molti brand internazionali e italiani che, quotidianamente, vengono indossati.
Ogni anno si celebre il “fashion revolution day” che, nel ricordare le vittime del crollo, ha l’obiettivo di:
a) promuovere una industria della moda “sostenibile” e quindi rispettosa dell’ambiente e di coloro che vi lavorano;
b) sensibilizzare i consumatori sul “chi” e sul “come” vengono realizzati i “capi” di abbigliamento che si apprestano ad acquistare ed indossare (who made my clothes).
Parlare di tradizione tessile, in Molise, significa (anche) rievocare l’importante esperienza imprenditoriale della Ittierre (e prima ancora della Pantrem – POP 84) che segnò lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Una esperienza imprenditoriale che formò un patrimonio di competenze che contribuì al successo di tanti brend del lusso: Trussardi, Versace, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, Just Cavali e tanti altri.
Una esperienza imprenditoriale attorno alla quale si formò un diffuso sistema di imprese, particolarmente presente nelle aree interne, caratterizzato da elevati livelli occupazionali prevalentemente femminili.
Nel 2001, la rilevazione Istat sui distretti produttivi meridionali segnalava una significativa concentrazione di aziende del settore moda nell’area “Trivento – Montenero di Bisaccia”.
Poi la delocalizzazione produttiva in Paesi a minor costo del lavoro e la crisi della Ittierre, frantumarono quel modello di sviluppo e causarono la perdita di centinaia di posti di lavoro e il declino economico e sociale del nostro territorio. Nel volgere di pochi anni, quelle maestranze che avevano contribuito al successo di tante griffe della moda, si trovarono poste ai margini dei processi produttivi e le loro competenze creative e manifatturiere furono considerate non più “funzionali” e, quindi, da “rinconvertire”.
Poi lentamente lo scenario è cambiato. E’ emerso un nuovo profilo di consumatore più “evoluto” e attento al rapporto qualità-prezzo, alle caratteristiche “etiche” dei “capi” indossati, al rispetto dell’ambiente e di coloro che vi hanno lavorato. Un consumatore che chiede una “moda sostenibile”, costituisce una opportunità per quelle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente, di coloro che vi lavorano e degli stessi consumatori, a scapito di quelle aziende orientate prevalentemente sulla ricerca del “minor costo dl lavoro” (con le conseguenze sopra richiamate).
Con il “reshoring” (ovvero il rientro in Italia delle produzioni – moda in particolare – precedentemente delocalizzate nei Paesi a minor costo del lavoro) infine, sono tornate di attualità le filiere “corte” (a Km 0) che possono favorire il recupero e la valorizzazione di quella maestria manifatturiera che appartiene al DNA italiano.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma di azione sottoscritto, nel settembre 2015, da 193 Paesi membri dell’ONU che, nell’esprimere un chiaro giudizio di insostenibilità ambientale, economica e sociale dell’attuale modello di sviluppo, punta a costruire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.
Attraverso 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (articolati in 169 target), l’Agenda 2030 supera, definitivamente, l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e afferma, invece, una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo: economica, sociale ed ecologica.
In questo contesto si colloca la richiamata strategia adottata della Commissione Europea per il sistema moda, al centro dell’iniziativa “ReSet the trend”, che punta, entro il 2030, su produzioni tessili: durevoli, riciclabili, privi di sostanze pericolose e rispettose dei diritti sociali e ambientali.
Cultura, creatività, sostenibilità sono, dunque, le parole che, in sintonia con questi indirizzi, animano la “moda sostenibile” che, intercettando gli orientamenti dei consumatori, ci consente di riscoprire e valorizzare l’arte manifatturiera che contraddistingue la nostra tradizione tessile.
Tradizione, questa, che affonda le sue radici nella pratica della “transumanza” (inserita dall’Unesco tra i patrimoni culturali dell’umanità) e in quel patrimonio di competenze moda locale che, marginalizzate negli anni scorsi dalla delocalizzazione e dalla crisi dell’azienda leader, può tornare al “centro” dei processi produttivi proprio in virtù delle richiamate nuove tendenze (Slow fashion, reshoring).